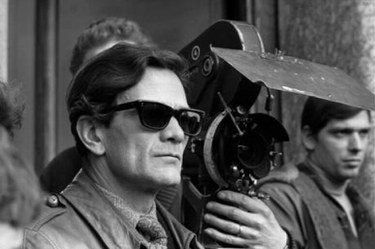curiosità

Opere d'arte nel deposito del MAMbo (foto di Giulia Carbone)
«C’è un falso mito sui depositi dei musei. Si crede erroneamente che celino tesori. In realtà se ci fosse un Van Gogh è certo che verrebbe esposto», ha detto Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo di Bologna ai microfoni di Incronac@. MAMbo è il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Bologna e conta ben 5000 opere di cui però solo 200 esposte. Nelle grandi istituzioni museali, infatti, l’esposizione nelle sale rappresenta sola una piccola porzione di un patrimonio artistico più corposo. E questo vale tanto più in Italia, dove gran parte dei musei sorge in edifici storici e dunque è il patrimonio storico-artistico ad adattarsi agli spazi preesistenti. Un problema, questo, mitigato in parte dalla possibilità di ruotare le opere esposte decidendo di volta in volta il focus della collezione mostrata. «Si può essere più incisivi su un determinato momento artistico: se ci riferiamo all'ultimo naturalismo potremmo tirare fuori diverse opere dal nostro magazzino - spiega Balbi - Non possiamo però ruotare interamente la collezione, poiché ci sono alcuni quadri che il pubblico ricerca. Difficilmente riusciremo, ad esempio, a togliere "I Funerali di Togliatti" perché un'opera fortemente identitaria della nostra collezione, legata all’apertura del museo», conclude il direttore. Si tratta di un dipinto realizzato nel 1972 e donato al MAMbo dall’autore stesso Renato Guttuso, in occasione dell’apertura del museo. La tela è un esempio del forte impegno civile dell’artista e raffigura i protagonisti del movimento comunista internazionale, da Stalin a Berlinguer. Lo stesso discorso può essere applicato all’architettura cacognometrica ideata da Gianni Colombo, entrata nell’immaginario collettivo dei visitatori del MAMbo. Opere, dunque, che il dipartimento curatoriale tende a lasciare nella collezione permanente benché non siano inamovibili. Il magazzino viene così valorizzato soprattutto grazie alle mostre temporanee, rispondendo a un approccio sia storico che tematico: dietro alla scelta di quali "titoli" estrarre c’è un lavoro scientifico. In questo modo il deposito museale non si limita a essere un luogo fisico statico ma diviene un museo vivo. Ovviamente, una volta scelta la tematica di una mostra, non c’è una ricetta pronta su quante opere vengano prelevate dal deposito e quante possano provenire da un prestito intra-museale. «Non mi è mai capitato di curare una mostra temporanea con opere totalmente provenienti dalla collezione», ammette Balbi parlando di “dialogo” tra collezione e prestiti. Al Museo Morandi, per esempio, è stata messa in mostra una personale di Sean Scully, uno tra i 10 artisti viventi più influenti al mondo, perché il direttore ha visto un attinenza formale e concettuale di queste opere con l’eredità di Giorgio Morandi. Ma com'è fatto un luogo destinato a essere deposito? Nel caso di MAMbo, lo spazio è diviso in tre diverse zone contrassegnate da lettere per facilitare le operazioni. Il patrimonio demaniale contenuto all’interno è diviso in collezione storica e collezione contemporanea a cui si aggiungono quadri e grafiche della collezione Morandi. Il problema dello spazio diventa cruciale perché il museo di arte contemporanea bolognese, in quanto istituzione pubblica, non può vendere nulla della propria collezione ma riceve periodicamente nuove opere. «Si tratta di giocare a tetris», spiega la responsabile del deposito Barbara Secci. E in effetti 96 opere del MAMbo si trovano in depositi esterni per questioni di spazio. La parte più consistente del patrimonio conservato riguarda le opere di grafica (1784) seguite da opere su tela, su carta e scultoree. Quarantadue sono date poi in comodato d’uso ad altri musei e dieci di queste sono esposte. Vi sono poi diverse installazioni contemporanee che vanno smembrate per poter essere conservate nel miglior modo possibile. La temperatura del deposito rimane costante, sui 22 gradi, con un’oscillazione accettata dal facility report di 2 gradi. Il tasso di umidità invece è del 50% e le finestre restano ovviamente sempre chiuse per evitare i danni della luce. Veniamo ai dettagli. Ogni pezzo ha una determinata nomenclatura che individua il luogo esatto del deposito. La collocazione dipende dal tipo di fragilità e dalla sistemazione in cassa o meno. «Stiamo sperimentando un nuovo materiale, il Tyvek», continua Barbara Secci. Si tratta di un materiale completamente sintetico realizzato con fibre di polietilene ad alta densità e ottimo per la conservazione delle tele in quanto è idrorepellente, resistente all’abrasione, alla penetrazione batterica e all’invecchiamento. Nelle rastrelliere sono infine poste le opere materiche più delicate, senza vetro, opere d’arte contemporanea e sculture da appendere a parete. I depositi hanno sempre svolto quella che èla funzione principale del museo: la conservazione. Purtroppo, alcune dinamiche ostacolano questo obiettivo. Ci sono fattori tecnici (depositi riempiti oltre le capacità, mancanza di attrezzature adeguate) e fattori “ambientali” che entrano in gioco. L'ultimo esempio è l'alluvione in Emilia-Romagna, dove una piccola parte del patrimonio storico artistico è andato perduto. L'acqua ha messo in luce i ritardi accumulati dal nostro Paese in tema di conservazione efficiente e l’urgenza di investire in prevenzione invece che in restauro. L’ex assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Mauro Felicori, a gennaio 2024 era stato chiaro in merito alla questione: «Sono stati sommersi dall’acqua 31 archivi, 13 biblioteche e diversi teatri e i loro depositi sono ancora inagibili. È un tema negletto, l’ultima priorità sul tavolo degli amministratori. Inaugurare e gestire archivi e depositi non è popolare». Per far fronte all’onda d’urto, l’azienda ferrarese Makros, ha creato un brevetto contro il fuoco a cui sono seguiti quelli contro l’acqua e batteri. È un chiaro esempio di tecnologia a servizio dell’arte. In merito al funzionamento, il fondatore dell’azienda Massimo Luise ha spiegato ai microfoni di Incronac@ che «quando questi particolari armadi si chiudono, sono coibentati e protetti da una fibra che resiste a mille gradi di temperatura: si crea così un guscio protettivo. Persino dopo diverso tempo di esposizione al fuoco, la carta rimane intatta». La meccatronica, dunque, si congiunge con la cultura e garantisce la salvaguardia del patrimonio ma non certo a un costo esiguo: «Tutelare un metro di materiale costa anche mille euro. Per ristrutturare una pagina di un documento antico servono anche 800 euro. Ma per noi è importante farlo per il valore culturale del materiale che altrimenti andrebbe perduto. Questo va oltre ogni spesa», ha concluso Massimo Luise. Sono diverse le soluzioni internazionali proposte per far fronte al problema dello spazio ma allo stesso tempo alla valorizzazione dei depositi museali. Ancor prima dell’inaugurazione ufficiale del 5 novembre 2021, il deposito del museo Boijmans a Rotterdam veniva presentato sui giornali di tutto il mondo come primo deposito museale aperto al pubblico. L’Olanda è un esempio positivo su questo fronte: la recente creazione di depositi museali si innesta, infatti, in un processo ben più vasto di ammodernamento della conservazione, reso possibile da un programma governativo. Anche il Victoria & Albert Museum di Londra ha riportato alla ribalta l’attualità dei depositi come riserve museali, con i suoi 16mila metri quadrati e oltre 250mila oggetti. Il report mondiale del network Icom del 2024 svela come le riserve museali si accumulino occupando vaste aree del pianeta (103.852 metri quadrati nel mondo, di cui 3.195 in Italia) con tipi di spazi diversi, annessi o dislocati ai musei. Ed è soprattutto l’allestimento, la matrice architettonica che fa la differenza nel porre in evidenza la possibilità della riserva museale a essere reinterpretata come “ecologia della collezione”. A esplicare il concetto il nuovo libro di Tiziana N. Beltrame e Yael Kreplak prende in esame la situazione museale francese che conta sul suo territorio ben 40.811 depositi. Portando avanti uno studio sul campo, a sfondo antropologico e sociologico, i due studiosi hanno riscontrato che l’”ambiente deposito” diviene un modo per interleggere le relazioni tra corpi. Il corpo umano di coloro che vi lavorano, i corpi degli oggetti che vi convivono e il corpo dello spazio architettonico. Dunque, il deposito divienecosì l’ambiente privilegiato per intravedere i musei del futuro o il futuro dei musei. In merito, però, a una possibile futura mostra al Mambo che racconti il dietro le quinte del proprio deposito il direttore Balbi si dice perplesso. «Non credo possa funzionare, il museo ha ormai 50 anni ma la collezione al suo interno ne ha quasi 100, è un giocoforza che va a nostro sfavore, la collezione presenta discontinuità nella sua composizione. Ci troviamo in un momento di crisi economica, non c’è un vero piano di acquisizione, cosi come non lo hanno la maggior parte dei musei pubblici italiani. Quello che possiamo fare è avere un approccio tematico, trans-storico, che ti permette di valorizzare quello che hai». In conclusione, portare alla luce quello che dorme nei depositi non è solo questione di spazio, ma di risorse, di priorità, di visione. Finché i bilanci resteranno più pesanti delle casse, molte opere continueranno a vivere una vita sospesa. La bellezza ci resta invisibile allo sguardo.