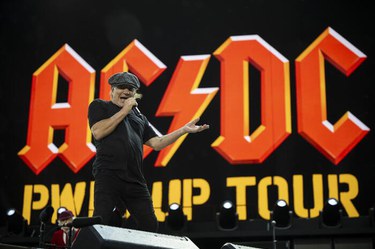L'approfondimento

Per gentile concessione di Helga Schneider
L’antisemitismo ha rialzato prepotentemente la testa, dentro e fuori l’Europa. Questa forma di odio e pregiudizio, mai debellata del tutto, si è aggravata negli ultimi tempi con il conflitto israelo-palestinese, e oggi come ieri si scontra con lo sforzo che si fa nelle scuole e nelle università per capire la Storia con coscienza e obiettività.
In questo clima politico e culturale così intenso, è fondamentale ascoltare le voci di quelle persone che hanno vissuto da vicino la follia dell’antisemitismo, gli orrori del nazismo, all’interno di quella cornice sanguinosa che è stata la Seconda guerra mondiale. Queste voci, che sono sempre di meno, sono quelle dei sopravvissuti all’Olocausto, oppure quelle dei nonni, dei parenti che hanno toccato con mano la distruzione della guerra, da ascoltare per non dimenticare il male del passato e fare così chiarezza nel tempo presente. Tra queste, c’è quella forte e decisa della scrittrice tedesca, ma bolognese d’adozione, Helga Schneider, nata in Slesia (oggi regione della Polonia) nel 1937, la donna che ha conosciuto Hitler da bambina nel suo bunker di Berlino.
Non è un caso che poco prima del Giorno della Memoria, sia uscita nelle librerie la sua ultima fatica letteraria, Hitler. Mai prima di mezzogiorno (Oligo Editore). A metà strada tra saggio storico e romanzo, il libro è una dettagliata ricostruzione della barbarie nazista e degli ultimi mesi di vita di uno stanco e malato Adolf Hitler.
«Ho scritto questo libro perché sono una testimone, scrivo per testimoniare. Io vivo a Bologna, ma ho vissuto nel Terzo Reich, un momento storico ancora interessante. Spero di aver fatto bene», queste le prime parole dell’autrice in occasione della presentazione ufficiale del volume.
La scrittura di Schneider è spiazzante, rivela il reale nella sua crudità, nella sua veridicità. Nel libro descrive nel dettaglio la figura di Hitler per quello che era negli ultimi tempi prima della caduta, cioè un uomo senza gloria, nascosto nel suo bunker per sfuggire ai bombardamenti degli Alleati, lontano dal suo popolo, lasciato alla mercé di morte e privazioni.
Il suo stile è così autentico perché è stata un’osservatrice lucida degli orrori della guerra. Non un’ebrea, non una rom o un’oppositrice politica, ma una semplice bambina berlinese abbandonata, senza apparente motivo, dalla propria madre, e costretta a sopravvivere tra le macerie della sua città.
«Tutta Berlino stava nelle cantine – racconta – l’immondizia veniva scaricata sulle strade, un odore terribile per le strade, accanto ai cadaveri in decomposizione che non si spostavano più».
La gente soffriva e moriva nell’indifferenza, mentre gli Alleati erano puntuali nello sganciare le bombe dal cielo, per spazzare via tutte le difese del Reich. E intanto Hitler se ne stava nascosto sottoterra, con elettricità, acqua corrente, viveri.
Le famiglie della capitale vivevano in un tremendo stato di degenza: «Difficoltà a trovare acqua, cibo, niente luce, le candele facevano bruciare gli occhi… le persone anziane non trattenevano l’urina», afferma.
Si mangiava quello che si raccattava per strada o nei palazzi semidistrutti, come le bucce di patate, mangiate dalla stessa Schneider, per poi soffrire di dissenteria.
In questo contesto si inserisce il faccia a faccia con Hitler nel dicembre del 1944. La sorella della sua matrigna lavorava per Goebbels al Ministero della Propaganda e riuscì a coinvolgerla nel programma propagandistico “i piccoli ospiti del Führer”. Ancora oggi Schneider rammenta ogni singolo dettaglio di quel giorno: «Si arrivava con un bus, aperto il portello di cemento si scendeva. Il bunker era spettrale, brutte luci, cattivo odore, davvero spaventoso. Ho visto Hitler davanti a me per dieci minuti, mi ha dato la mano, ci siamo guardati negli occhi; era messo malissimo. Sei hai visto una volta il volto di Hitler, è difficile dimenticarlo».
Invece di una personalità forte, in salute, atletica, ancora in grado di guidare la nazione, si ritrovò di fronte a un uomo finito. Il presuntuoso dittatore, sempre elegante, era un uomo debole e malato, non il semidio che la propaganda sventolava.
«L’uomo ha il destino di tutti gli uomini», sentenzia Schneider.
Hitler era diventato «una larva umana», sebbene ancora capace di scatenare la sua spietatezza, e poi «vigliaccamente si è sparato, si è sottratto alle sue enormi responsabilità».
Grandi cambiamenti nella sua vita cominciano anni dopo la fine della guerra. A diciassette anni se ne va di casa, per poi viaggiare per l’Europa e per l’Italia con un’amica. Nel 1963 avviene il trasferimento a Bologna e da lì la costruzione di una famiglia sua.
Dopo qualche anno, decide di cercare quella madre che durante il conflitto aveva abbandonato lei e il suo fratellino. Nel 1971 la trova, a Vienna, e va a farle visita con suo figlio, di cinque anni. Ciò che scopre durante quell’incontro la segna in maniera indelebile: la madre le aveva detto addio per arruolarsi nelle fila di volontari delle SS, per poi diventare una guardiana della sezione femminile del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
«Forse avrei avuto bisogno dello psicologo per mettere ordine nel mio cervello, ma scrivere libri mi ha salvata», riflette Schneider su quel giorno del 1971. Sarà poi lei a rinnegare la madre, mai pentitasi del suo passato da criminale di guerra, fiera della sua uniforme, decisa a donarla alla figlia ormai adulta, assieme a vecchi gioielli di provenienza ignota.
«Era ancora convinta che Hitler aveva fatto bene a sterminare gli ebrei, perché secondo lei “quella sporca razza era colpevole di tutti i guai e problemi che aveva la Germania”», rivela.
Da questa esperienza traumatica nascerà il memoriale Lasciami andare, madre, del 2001, uno dei suoi titoli più celebri.
La vita privata di Helga Schneider è storicamente molto rilevante, ma anche l’inizio della sua carriera di scrittrice è degno di interesse. Dopo aver lavorato per una ditta (poi fallita) come traduttrice dal tedesco all’italiano, viene assunta in una stireria e da quel momento comincia a scrivere del tempo della sua infanzia a Berlino e della guerra, fino a dare alla luce la sua opera prima, Il rogo di Berlino, considerata il suo capolavoro.
«Il peso della mia infanzia, della guerra, lo sento ancora», ammette.
Il suo agente letterario, Luigi Bernabò, riesce a far leggere il manoscritto al celebre direttore editoriale di Adelphi, Roberto Calasso, che decide di pubblicarlo nel 1995. Calasso crede in lei e nel suo libro, nel suo mestiere di testimone, tanto da chiederle di continuare a narrare il suo vissuto. E così, a cinquantotto anni, diventa in breve tempo un’autrice affermata, che continua a scrivere perché non può farne a meno.
«Io devo scrivere, per ore, ho la malattia dello scrittore. Amo scrivere, mi fa stare bene, mi unge il cervello. La scrittura mi ha salvata», dice.
Oggi è una scrittrice di fama nazionale e internazionale e i suoi numerosi titoli – tra romanzi, racconti per ragazzi, saggi e memoriali – appartengono al catalogo di svariati editori italiani, grandi e piccoli, da Adelphi (che oltre al Rogo di Berlino ha pubblicato Lasciami andare, madre) a Einaudi, da Salani a Pendragon, uno dei marchi editoriali simbolo di Bologna. Non meno importante il fatto che abbia scelto di scrivere le sue storie in italiano, la sua amata lingua adottiva.
La sua attività di testimone è molto forte non solo nel panorama editoriale, con presentazioni di libri e conferenze, ma anche nelle scuole, dove parla ai ragazzi della sua vita e di come sia fondamentale assimilare la Storia, saper riconoscere il falso e la manipolazione, soprattutto in quest’epoca di ritrattamenti, di rinnegamenti del mondo di ieri.
«È indispensabile studiare la Storia, perché è indispensabile sapere cosa è successo prima di noi, per evitare che il presente commetta gli stessi errori», è il suo messaggio agli studenti.
Un impegno certamente considerevole, visto l’odierno clima politico europeo, caratterizzato da conservatorismi di destra, da forze parlamentari come il partito neonazista tedesco Alternative für Deutschland (AfD), che avanza nei sondaggi per le elezioni politiche di fine febbraio.
Nonostante questi ostacoli sociali e culturali, Helga Schneider continua instancabile il suo lavoro, per far sì che tragedie come l’Olocausto non finiscano per essere «solo due righe su un libro di storia».
L'approfondimento è tratto dal n.1 del Quindici uscito il 9 aprile 2025